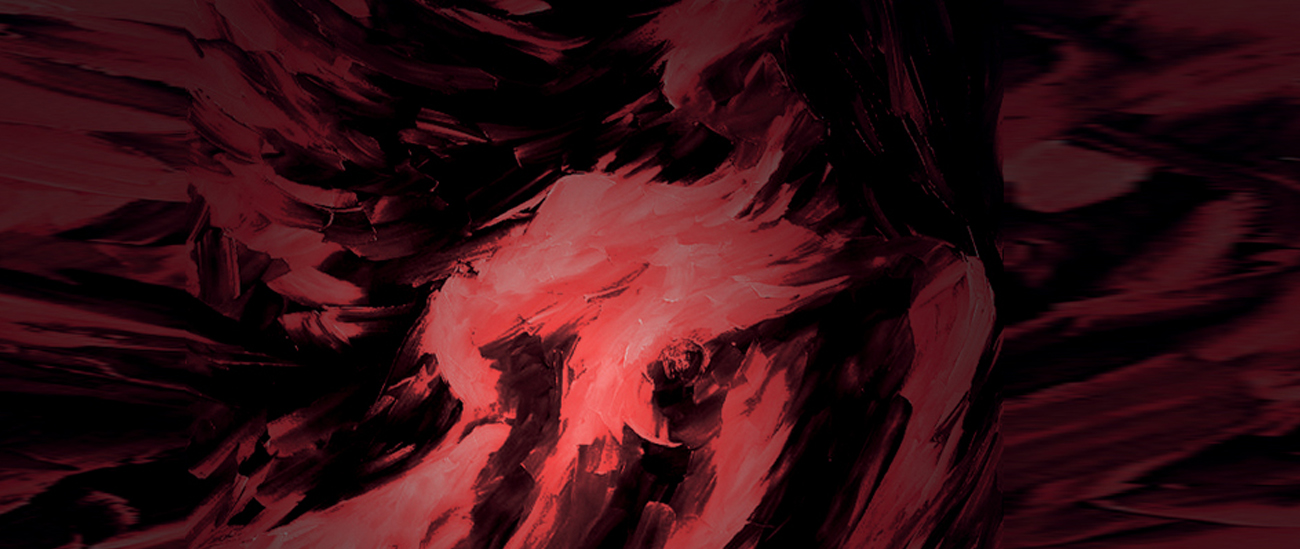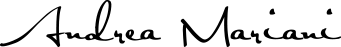Il bosco di Delville
Fissavo la linea dell’orizzonte con gli occhi incollati verso un’indefinita alba, velata dalla foschia autunnale giunta da nord-est che si era formata nottetempo, riempiendo l’intero campo. Ero infreddolito, affamato e stanco. La pioggia cadeva da due giorni oramai; di quella sottile e fitta che pizzica la faccia e sfinisce l’animo. L’acqua aveva trasformato la terra in un pantano appiccicoso, dove gli stivali affondavano fino alle caviglie per poi incastrarsi e rallentare qualsiasi tipo di movimento, scoraggiando persino ogni intenzione di compierlo. Nella radura scorgevo decine e decine di pozzanghere, tanto grandi da sembrare una miriade di piccoli stagni radunati in una desolata palude. Sentivo il tabarro sempre più pesante e zuppo, mentre l’elmetto che indossavo era percosso dal ticchettio delle gocce d’acqua che, dopo due giorni, sembravano bordate di cannoni assordanti per i miei timpani. Il mio secondo giorno di trincea, alle soglie del bosco di Delville, iniziò così: una guardia notturna, per impedire al nemico tedesco di avanzare e massacrarci tutti nel sonno.
Una mano picchiettò sulla mia spalla, verso le sette, ed io rinvenni da un torpore profondo, in un misto di veglia e sonno molto simile all’ipnosi. Forse non vi è mai capitato di trovarvi nella condizione di dover privare il vostro corpo e la vostra mente del riposo ristoratore, in un contesto di estrema e continua tensione; ebbene, vi posso assicurare che, dopo le prime trentasei ore, il cervello inizia una tragica lotta tra quello che definirei senso del dovere, nel mantenere la lucidità necessaria a svolgere il compito prestabilito, e lo sfinimento della volontà, che vorrebbe lasciarsi andare all’onirico abbandono. Quel lieve tocco, nonostante sapessi di trovarmi dalla parte giusta del campo e fossi pienamente cosciente del fatto che non vi fosse pericolo imminente, ebbe il potere di farmi sobbalzare sul posto e riempire il mio cuore, almeno per un istante, di una terribile paura.
«Scusami Bill, non volevo spaventarti… Sono il tuo cambio».
Dietro di me scorsi gli occhi castani di Milton, un commilitone della 41ª brigata, 8° battaglione del Corpo Reale dei Fucilieri di sua maestà Re Giorgio V, di cui entrambi facevamo parte. Aveva il viso segnato dalla stanchezza, nonostante avesse dormito quella notte; ma era al fronte da molto più tempo di me e ciò che aveva vissuto, superava di molto le mie fatiche. Tuttavia, pur sentendomi particolarmente egoista, confesso che fui contento di vederlo e di prendere il suo posto nella retrovia. Certo dormire di giorno non è la stessa cosa che farlo durante la notte, non essendoci la stessa quiete e oscurità; ma ci misi poco meno di due minuti per addormentarmi profondamente, una volta messo al riparo il mio fedelissimo Enfield ed essermi accucciato a terra in modo da non disturbare il passaggio di coloro che erano pronti, invece, ad incominciare la giornata.
«Svegliati Foster!».
Quelle parole mi giunsero da lontano, come fossero proferite attraverso uno stretto e lunghissimo tunnel. In principio mi sembrò che facessero parte dello stesso sogno, ma lentamente mi riportarono alla superficie della realtà e al mio corpo intorpidito dal freddo, dove sembrava che tutta l’umidità del mondo si fosse concentrata nelle mie ossa.
«Perdonami ragazzo, ma ho bisogno di te».
Il capitano Ellis si sedette vicino al mio giaciglio, proprio accanto al fuoco. Mi mise in grembo una scodella di porridge fumante e poi dispose i palmi delle mani in modo che la fiamma di quella nostra stufa da campo improvvisata vi infondesse un poco del suo tepore.
«Ti chiedo scusa ragazzo… so che smonti dalla guardia notturna, ma non ho altri uomini per questo incarico. Devi tagliare per il bosco e trovare il nostro campo a Croiselles, che dista circa a cinque ore di marcia da qui, per portare un dispaccio al Generale. Dovrai andarci a piedi e viaggiare leggero… un cavallo ti sarebbe solo d’impiccio tra gli alberi della boscaglia. Si tratta di una missione della massima importanza… Dovrai consegnare il dispaccio al generale in persona e attendere una sua risposta».
Ascoltai le sue parole con estrema attenzione, prima di realizzare che avrei dovuto affrontare quella missione da solo. Avevo dormito circa sei ore, preda dello sfinimento, e non mi ero per niente accorto degli spari che ora udivo dal campo.
«Stanno attaccando Sir?», chiesi allora, timoroso per la mia sorte.
Il capitano annuì con fare serioso e poi aggiunse: «Partirai appena pronto, ma non temere, non dovresti incontrare resistenza da qui alla tua meta. Ci siamo noi a fare da tappo e nessun tedesco supererà la mia trincea; non fino a che avrò fiato in corpo, almeno». Terminò quest’ultima frase con un gran sorriso, proprio sotto ai suoi baffi folti e ricurvi, dove io vi lessi però un oceano di inquietudine.
Fui pronto a partire in quindici minuti. Preparai l’equipaggiamento leggero per la missione: il mio fucile con due caricatori completi, la pistola, una borraccia, una mappa con bussola, l’attrezzatura per la pioggia e tutto il coraggio di cui disponevo. Afferrai anche una salsiccia dalla mia razione, per un pranzo veloce, divorandola in tre morsi. Il capitano mi consegnò la sua preziosa busta con una pacca sulla spalla e poi svanì nel trambusto generale: i mortai nemici avevano iniziato a sputare fuoco. Mi misi a correre verso nord, proprio nel momento in cui smise di piovere. Superai il nostro accampamento e presto mi ritrovai distante dalla battaglia, nonostante i suoi boati mi sembrassero ancora tanto vicini. Di fronte a me comparve la foresta in tutta la sua magnificenza: intonsa, non ancora contaminata da tutta quella follia e distruzione che viveva alle mie spalle. Vi entrai senza aspettare un solo minuto, come se il diavolo in persona mi stesse alle calcagna.
La foresta era fitta e priva di un vero e proprio sentiero che l’attraversava. Sembrava sospesa tra due realtà: una viveva al di fuori di essa, fatta dagli uomini e dalla loro sovranità incontrastata; l’altra, al suo interno, era colma di una quiete assoluta e antica come il mondo, tanto da suscitare, in tutti coloro che vi si imbattevano, una profonda riverenza. Il suolo era diventato uno scuro tappeto marrone, formato da aghi di pino impastati alle foglie avvizzite che gli alberi lasciavano cadere nel gelo, come cadaveri gettati in una sterminata fossa comune: accumulati nel fango, ad attendere una lenta decomposizione. Mi circondavano i colori di un acquarello stinto, diluiti nel fumo e nella penombra. I suoni della battaglia, ad ogni mio passo, si facevano sempre più lontani, fino a sembrare l’eco attutito dei tamburi di una tribù di selvaggi. Assicurai la cinghia del mio fucile alla spalla sinistra, in modo che vi pendesse senza recarmi noia nel trasporto, ma badai che fosse abbastanza comodo imbracciarlo nel caso in cui fosse stato necessario. La solitudine della marcia mi avvolse. Ricordo con estrema lucidità quanto accadde di lì a poco e ciò che sono in procinto di narrare non è altro che la cruda verità di una disgrazia senza eguali. Consultai la mappa diverse volte quel giorno, cercando di tracciare una linea retta immaginaria che mi conducesse, nel minor tempo possibile, al di fuori dell’intreccio della selva. Avevo camminato nelle sue viscere per quasi due ore abbondanti, quando, all’improvviso, mentre mi apprestavo a discendere l’ennesima e insidiosa pendenza, misi un piede in fallo e tracollai malamente. La pendenza del terreno mi fece ruzzolare per molto tempo. Sentii su di me la mano di una sorte avversa, spingermi ancora e ancora, in un groviglio di rami che mi graffiarono il viso fino a lacerarlo sulle guance e poi su una roccia appuntita che sfiorò la mia testa. Caddi solo per una manciata di attimi, s’intende, ma a me sembrò un’eternità: il mondo sottosopra, il fango, la stanchezza e quella dannata sensazione di impotenza. Quando finalmente la caduta si arrestò, mi trovai cosparso di sudiciume dalla testa ai piedi e dolorante in ogni muscolo. Sentivo che le ginocchia erano ferite, perché avvertivo il sangue colare da sotto le vesti: caldo, viscoso. Il mio fucile Lee Enfield si era staccato dalla cinghia di cuoio e nello sganciarsi, mentre capitombolavo senza controllo, aveva premuto contro la spalla procurandomi una dolorosa distorsione, prima di scomparire dalla mia vista. Era forse rimasto incastrato in qualche anfratto durante la discesa? Controllai di avere ancora la fondina della pistola e la trovai, con un sospiro di sollievo, ancora attaccata al cinturone. Non so descrivere la fatica che feci nel rimettermi in piedi: un gesto che, in circostanze normali, mi sarebbe stato facile quanto respirare; ma in quel momento mi costò molte energie. Dal nulla, avvertii il rumore sordo e metallico di un meccanismo. Durò appena un battito di ciglia, prima che l’ondata di dolore sconvolse ogni mio senso. La tagliola si chiuse sulla mia caviglia con una morsa titanica, lacerando gli stivali, i pantaloni e straziando le carni fino all’osso. Urlai con quanto fiato avevo in corpo e una forza che non pensavo di possedere. Ogni percezione che avevo dell’ambiente, ogni mio senso, si distorse bruciando nella fitta dolorifica più intensa che avessi mai provato. Stramazzai ancora una volta al suolo, tentando di divincolarmi; ma più mi muovevo, più quell’atroce male cresceva e pungeva fino a lambire il cervello. Tentai, in preda alla disperazione, di forzare il marchingegno a mani nude, ma prima ancora di riuscire ad allungarmi verso di esso e la fonte del dolore, persi i sensi.
Giorno 1
Le prime luci dell’alba mi destarono con una discrezione quasi materna. Riacquistai la coscienza di me stesso lentamente, credendo di aver appena sognato l’incubo più angosciante che mente umana potesse generare; poi provai a muovermi, tornando alla realtà con una violenza che non avrei mai voluto sperimentare. Sentii i denti di quella creatura di metallo stringersi e spingere senza tregua contro la mia carne. Mugolai il mio dissenso, soffocando nelle lacrime della disperazione. Avevo dormito una notte intera, mancato il mio compito e, quasi certamente, sarei morto li, come una bestia.
Non sono mai stato un esperto cacciatore. La mia è una famiglia di pescatori e io sono sempre vissuto a Brighton: una città di modesta grandezza situata nell’Inghilterra meridionale, a ridosso della costa; eppure non ci misi molto a capire di essere lo sfortunato scopritore di una dannata trappola per orsi. Maledissi i francesi e tutti coloro che si divertono a cacciare in quel modo barbaro e senza onore, trascinandomi in un vortice di delirio e rabbia che mi inghiottì, come fossi un boccone succulento da assaporare nella sua interezza. Ricordavo le parole di mio padre che disprezzava ogni forma di arma da fuoco. Quanto l’avevo deluso arruolandomi nell’esercito di mia volontà? Quell’uomo che mi aveva cresciuto amorevolmente, senza mai aver fatto mancare nulla né a me e tantomeno alle mie sorelle. Per una vita intera si era alzato a notte fonda per lavorare sulla sua barca e assicurarci un futuro. Un figlio degenere, questo ero stato. L’irriconoscenza che dimostravo con quella divisa mi avrebbe annientato negli anni, trasformandomi in qualcosa che non volevo essere. Eppure era stato per sfidare la sua autorità che avevo preso la decisione di divenire un soldato; perché se c’era qualcosa ch’egli detestava di più delle armi da fuoco, erano i soldati che le brandivano. Sì, loro e i cacciatori tutti. La pesca, quella sì che era una forma d’arte. Dove la tecnica, mista all’astuzia dell’ingegno umano, avevano la meglio sull’istinto animale e la natura, quand’anche il mare si ribellava e la collera di Re Nettuno si sovrapponeva alla sfida. Quante volte, durante i suoi riposi domenicali in famiglia, aveva ripetuto quello stesso discorso? Fino alla nausea probabilmente, perché ricordo un tempo in cui lo odiavo; odiavo quelle parole che invece, ora, mi erano talmente care da sembrare una dolce melodia.
«Coraggio figliolo, reagisci!».
Ne sono certo, avrebbe usato queste parole vedendo le mie condizioni. L’uomo che mi ha cresciuto, ha affrontato una miriade di difficoltà nella sua vita e mai una sola volta ha ceduto il passo allo sconforto. Un uomo che persino della sconfitta avrebbe potuto farne un vanto.
Ripiegai su me stesso in posizione fetale e allungai le mani verso la ferita, con estrema cautela questa volta. Ero terrorizzato da quel dolore lancinante che toglieva il respiro e, certamente, avrei venduto l’anima a Lucifero in persona, se soltanto fossi stato certo che me ne avrebbe privato. Con la punta delle dita sfiorai il metallo grezzo della tagliola, poco prima di riuscire finalmente a sedermi. I suoi denti letali erano conficcati nella mia carne così profondamente che mi parve di vedere il pallido volto della tibia spuntare da sotto il tessuto, dove stivale e brache si erano lacerati formando un’unica poltiglia rossastra. Mi sembrava che nessuna arteria fosse compromessa, perché il sangue si era rappreso e non vi erano fiotti continui; inoltre ero ancora vivo e questo non era un particolare di poco conto. Risciacquai la ferita con l’acqua pulita della borraccia, sobbalzando per il bruciore che ne seguì. La fame e la sete assalirono le mie interiora improvvisamente. Avevo la sensazione che la copiosa perdita di sangue c’entrasse in qualche modo con la sensazione di stanchezza profusa che avvertivo e sapevo che l’unico modo per recuperare energie era bere e nutrirmi: un’operazione non del tutto semplice in quella condizione. Sarebbe quindi peggiorato? Avrei smarrito le forze fino a non riuscire più a muovermi? Improvvisamente una malsana idea, alimentata dalla collera, si insinuò nei miei pensieri e con un gesto sconsiderato afferrai, con entrambe le mani ed ignorando la distorsione alla spalla, quell’arnese maledetto che mi imprigionava, incatenandomi ad un tragico destino. Contai fino a tre e poi, con tutta la forza delle braccia, cercai invano di aprirla. Tornò il dolore, questa volta più intenso, per punire il mio affronto; ma più provavo dolore, più mi adiravo, continuando nell’impresa con energia crescente. Tentai quindi con un bastone che rimediai dal terreno e ancora un grosso sasso che picchiai violentemente sul suo profilo ricurvo. Il sangue riprese a sgorgare lentamente, come fuoco liquido lungo l’orribile lacerazione. Sfoderai la baionetta dal cinturone e presi ad armeggiare. Alla fine, rimanemmo soltanto io, le mie lacrime e gli spasmi della follia. Mai e poi mai avrei potuto muovermi. Il peso di quella cosa era insopportabile nelle mie condizioni e se anche dal campo avessero inviato qualcuno a cercarmi, nessuno avrebbe potuto trovarmi acquattato in quel dirupo. Pensai di urlare e richiamare l’attenzione di eventuali soccorritori, ma in tutta onestà non sapevo se e quando sarebbero venuti. Se soltanto ci fosse stato anche solo un tedesco nelle vicinanze, invece che un amico, allora mi avrebbe sicuramente sparato in tesa, come si fa con i cavalli zoppi, e sarebbe stata la mia fine: la più ingloriosa di tutte le fini oserei dire, perché avrebbe sicuramente deriso la mia sfortuna, raccontando agli amici di come aveva graziato quel poveraccio che era rimasto imprigionato da una trappola rudimentale, come il più grande dei fessi. Quanto avrebbe riso mia madre. Lei ha sempre amato le battute di spirito e l’ironia. Adoravo vederla ridere di gusto, con quella sua dentatura perfetta e gli zigomi pieni di colore. Sapeva sorridere anche nel mezzo della più oscura tristezza, come la luce che fende l’oscurità con un’esplosione di colori. Non l’avrei più rivista. La sua memoria sarebbe stata cancellata dall’oblìo del nulla che accompagna la morte; e lei non avrebbe nemmeno avuto una lapide su cui piangere suo figlio, perché il mio corpo si sarebbe consumato lì, in quella terra straniera, in mezzo al fango.
Passarono molte ore e mentre il mio cervello si torturava in un moto perpetuo, calò ancora una volta l’oscurità, con tutti i suoi sinistri bisbiglii e occhi in agguato che, mio malgrado, mi trascinò nell’incoscienza forzata di un tormentato sonno.
Giorno 2
Mi ridestai dopo essermi letteralmente urinato addosso. Il sole era già alto nel cielo e io non potei far altro che chiedermi se sarebbe stata l’ultima volta che l’avrei visto così intenso, in una mattinata tanto limpida. La catena che mi costringeva all’immobilità non era stata spezzata dalle fatate mani dei folletti e presto avrei scoperto, con orrore, che a volte la fantasia non dovrebbe affatto concedere spazio alla realtà. Mi resi conto di non sentire più il piede, come se al suo posto ci fosse stato soltanto un vivido ricordo. «Almeno non sento più dolore», dissi, scoppiando a ridere a crepapelle, in un attacco di puro isterismo. Mi avvicinai ancora alla ferita e qui rabbrividii nel vederla completamente coperta da una miriade di formiche indaffarate a spolparmi vivo. Piccoli pezzi di me venivano tagliuzzati e trasportati a nutrire la colonia, in una laboriosa catena di montaggio formata da migliaia di piccoli insetti voraci. Imprecai, scrollandomele di dosso con una furia assassina, travolgendole con la manica del mio cappotto e annegandole con l’acqua della borraccia. Il taglio si stava imputridendo, assumendo un colore pallido e malato. Decisi quindi di fasciarlo alla bell’e meglio con alcune delle bende del kit di pronto soccorso. Fu un’impresa terribilmente difficile. L’osso si era spezzato, ne avevo la certezza.
Pensai ad Ana, la bellissima fanciulla che, una volta tornato a casa, avrebbe dovuto diventare mia moglie. Le sue carezze, i suoi teneri abbracci, appartenevano ad ere remote e irraggiungibili. Avrebbe sposato un altro? Avrebbe comprato quella casa di cui avevamo tanto parlato e che sognavamo nel nostro futuro? I suoi figli si sarebbero chiamati Robert e Adam? Avrebbe versato tante di quelle lacrime da consumarsi, di questo ero certo, perché il nostro era vero amore, mica uno squallido gioco di finzioni e interessi, come purtroppo se ne vedono tanti; ma la sua vita, a differenza della mia, sarebbe continuata per molti e molti anni ancora. Certo, un giorno mi avrebbe dimenticato scordando persino il mio viso o la mia voce. Sì, perché sono i primi ricordi che, nonostante i nostri sforzi, solitamente scompaiono nelle inesorabili increspature del tempo. Ciò che rimane di coloro che ci lasciano è strettamente legato agli odori e alle sensazioni, ma perdiamo con facilità, nella nostra fragile natura di esseri umani, tutti i ricordi legati alla vista e all’udito, che spesso vengono influenzati e modificati dalla fantasia. Io però l’avrei ricordata per il tempo che mi sarebbe stato concesso: un altro giorno magari, un’altra ora o minuto. Non avrei perso nulla della sua meravigliosa e confortante memoria. Se ci penso, in effetti, era tutto quello che mi restava.
La ferita batteva e avevo la fronte madida di sudore: quello freddo, di una febbre alta e spossante.
Lei scendeva le scale della chiesa, avvolta da uno splendido vestito bianco e l’intero paese sembrava essersi fermato ad ammirarla.
Bevvi l’ultimo sorso dell’acqua che rimaneva dalla borraccia.
Ad attenderla, proprio davanti all’altare, c’era un ragazzo di bella presenza.
Sciolsi la copertura della fondina di cuoio ed estrassi la mia pistola d’ordinanza, stringendola nella mano, per poi sollevarla fino alla tempia.
Lui la baciò con estrema passione.
Armai il cane e poggiai il dito sul grilletto.
Poi, dal nulla, arrivò un ringhio feroce e un lupo mi si avventò contro, balzando fuori dai cespugli, azzannandomi all’altezza della coscia. Mi strattonò violentemente, schiumando dalle fauci, come se volesse farmi assumere una posizione più consona a scoprire il collo e le arterie vitali. Il panico colmò ogni centimetro del mio essere. Puntai e sparai senza pensarci. Fui investito da un latrato soffocato. Come avevo potuto essere tanto maldestro? Come avevo fatto a trascurare un dettaglio tanto importante? Gli animali del bosco, dopo tutto quel tempo, si erano certamente interessati a me e al comodo pasto che avrei rappresentato per loro. Non feci in tempo a pensarlo che altri seguirono il suo esempio, balzando su di me da più lati. Ero come una bambola di pezza senza vita, se paragonato al loro vigore. Disponevano di me come credevano, riducendomi ad un nulla. Uno di loro mi addentò proprio a ridosso della caviglia e solo allora trovai la forza di reagire. Ancora una volta, il dolore agì su di me come un’iniezione di adrenalina pura. Presi la mira e feci fuoco. I primi due colpi andarono a vuoto. Spari ancora: una, due, tre volte, per tre lupi che caddero esanimi, mentre la loro materia grigia si sparpagliava nel fango come una gigantesca macchia di rosso scuro, tanto densa da sembrare melassa. Il branco si disperse rapidamente, rintanandosi nella folta vegetazione.
Mi ritrovai coperto di sangue, allo stremo delle forze, con una caviglia maciullata dalla tagliola, una ferita infetta, un osso rotto e molte nuove contusioni che bruciavano.
Avrei dovuto accendere un fuoco.
Suo padre rideva di me, mentre stringeva la mano allo sposo. Mi guardava, come se fossi una presenza fluttuante ed eterea.
Non avevo più proiettili; se fossero tornati mi avrebbero sbranato.
Certo, aveva ragione. Come si poteva non ridere di un uomo come me? Un soldato avrebbe dovuto morire sul campo di battaglia, con onore; che razza di soldato muore ferito da una trappola per orsi, in un bosco dimenticato da Dio?
Frugai in ogni tasca del cappotto per trovare quello che speravo di non aver perduto nella caduta: una scatola di fiammiferi mezza piena che tenevo sempre, nel caso fosse capitato un po’ di tabacco alla portata della mia pipa. La trovai in una tasca interna e una gioia profonda mi colpì, come quella degli infanti che scoprono per la prima volta un pezzo di mondo che prima ignoravano. Tolsi il coperchio solo per accorgermi che erano tutti bagnati; tutti, tranne uno. Strappai un lembo della mia camicia servendomi della baionetta e mi misi ad accatastare quanta più sterpaglia riuscivo a trovare. La cercai scavando, attraverso un tappeto molliccio di foglie secche e fanghiglia, insieme ad alcuni ramoscelli di diverso spessore e dimensione. Poi trovai dei sassi grandi quanto un piccolo pugno e formai un cerchio all’esterno, delimitandone una piccola area. I lupi stavano tornando. Avvertivo la loro presenza e il loro respiro alle mie spalle. Ancora poco e mi avrebbero certamente attaccato. Guardai ancora quell’unico fiammifero rimasto: la sola speranza della mia temporanea salvezza. Lo strofinai con un gesto secco e questo prese fuoco immediatamente, con uno schiocco. La piccola striscia che avevo ricavato dalla camicia si incendiò. Con cautela la adagiai sulla sterpaglia, fino a che non iniziò a bruciare. Il suo calore si aprì lentamente, come la corolla di un fiore, balzando su e giù con un moto discontinuo. Aggiunsi i ramoscelli più piccoli e poi quelli più grandi, fino ad ottenere un falò. Sospirai quasi commosso per la tregua che ottenni. Ogni creatura del buio si disperse al cospetto di quella fiamma sempre più intensa e forte. Non avrei mai saputo dire fino a quando sarebbe durata, ma per il momento ero salvo… almeno dalle zanne dei lupi. Quella notte non chiusi occhio, nonostante fossi allo stremo delle forze e pregai il cielo che non venisse la pioggia.
Giorno 3
Ero inchiodato al mio letto di morte quando giunsero a me gli incubi di un pensiero macabro e diafano. Vidi, uno ad uno, i volti dei miei compagni sfilare tra i boschi, accompagnati da un’inquietante figura dai cerei lineamenti e le vesti scure. Stringeva a sé, con fierezza, una falce incrostata, mostrando loro una via apparentemente invisibile. Alcuni dei ragazzi si voltarono nella mia direzione e solo allora mi accorsi di quanto fossero angosciati i loro sguardi. Una paura tragica che ne contorceva i volti in espressioni deformi, del tutto estranee e inumane. Al loro passaggio ogni cosa si paralizzava, come fosse stata svuotata dalla vita e congelata dai ghiacci perenni. Mi fissarono e io sentii le loro voci chiamare il mio nome con insistenza; prima un sussurro, poi un suono profondo e ossessivo. Non badavo più alla mia condizione fisica, perché dopo aver visto la morte in carne ed ossa, soltanto quella dell’anima ebbe importanza. Al suo cospetto tutti siamo nudi, senza più un corpo che copre i nostri segreti più reconditi che, da vivi, celiamo maldestramente, come un fardello vergognoso e scomodo, per salvare le apparenze di un’esistenza menzognera. Sarebbe tornata a prendermi di li a poco. Quella sua inaspettata e orrenda visione, altro non era che un assaggio di ciò che sarebbe accaduto: una promessa scolpita con il fuoco e sigillata dal mio stesso sangue. Pensai che, in fondo, non ero ancora pronto a lasciare la mia vita… del resto, chi lo è mai? Piansi disperato, senza vergogna o ritegno. Se soltanto ci fosse stato un modo per cavarmi da quella situazione. Avrei fatto qualunque cosa per scampare a quel maledetto destino. Da quando avevo messo piede in quel bosco si erano innescati una serie di eventi a catena che non avevano lasciato scampo alcuno alla mia sorte, come se una mente superiore avesse pianificato la mia disavventura con meticolosa attenzione e una spiccata crudeltà. Ero certamente parte di un racconto e vivevo nella mente del suo scrittore che, con una maestrìa smisurata, lasciava cadere su di me una macabra favella riducendomi all’assoluta impotenza decisionale, in un gioco di ruoli sbilanciato e ingiusto. Io ero la marionetta e Delville, quel bosco dannato, il burattinaio impietoso. Quanto potevo resistere ancora senz’acqua né cibo? Quanto sarebbe bruciata la fiamma che impediva ai predatori di fare scempio del mio corpo? Poi arrivai alla madre di tutte le conclusioni; improvvisamente, con la fredda logica di un’analisi basata sui fatti. Gli alberi che mi circondavano, quei lupi, lo stesso terreno dove ero poggiato, facevano parte di un’unica creatura vivente e io ero l’intruso che aveva invaso il suo territorio, ignorando le conseguenze. Se il bosco esigeva quindi un pagamento per far fronte all’onta subita che avevo arrecato con la mia stoltezza, nel volerlo attraversare senza permesso, non mi restava altro che offrire la vita per placare la sua sete di giustizia. Mi sdraiai sul dorso nell’inerzia più totale, mentre il cielo sembrava rilasciare le prime gocce di una nuova pioggia. Ero pronto al sacrificio, se così doveva andare.
Pensai ancora ad Ana. La sua immagine, per un istante, mi scaldò il cuore. Poi, scattai seduto con un colpo deciso di reni, afferrai la baionetta e iniziai a segare. Prima incisi la stoffa e il cuoio di vesti e stivali, la mia pelle e ancora più a fondo muscoli e i tendini. Urlavo, grugnivo e sbavavo, ma mai fermai la mia mano. Mi liberai del peso della morsa e così di una parte del mio corpo. Il sangue scorreva come un fiume indomabile e il dolore implacabile consumò l’aria dei polmoni. L’abisso sotto di me si spalancò, mostrandomi l’oscurità assoluta che mi attendeva. Poi, d’un tratto, giunse a me il suono di alcune voci. «Fosteeer!», gridavano. I loro passi sempre più vicini alla mia posizione. Qualcuno mi toccò, scuotendomi e incitandomi a non abbandonarmi. Ero disteso su una barella; altri camminavano per me, conducendomi alla salvezza. Mi addormentai, ma prima di farlo non potei far altro che pensare a quella parte di me abbandonata, come un obolo sacrificato ad un’entità superiore. Non so spiegare se fu una semplice casualità o se invece si trattasse davvero di una forza quasi divina a rendermi la vita; né tantomeno se quel sacrificio avesse davvero modificato il corso degli eventi. Quello che posso dire con certezza, invece, è che da quel giorno non guardai mai più la natura con gli stessi occhi.